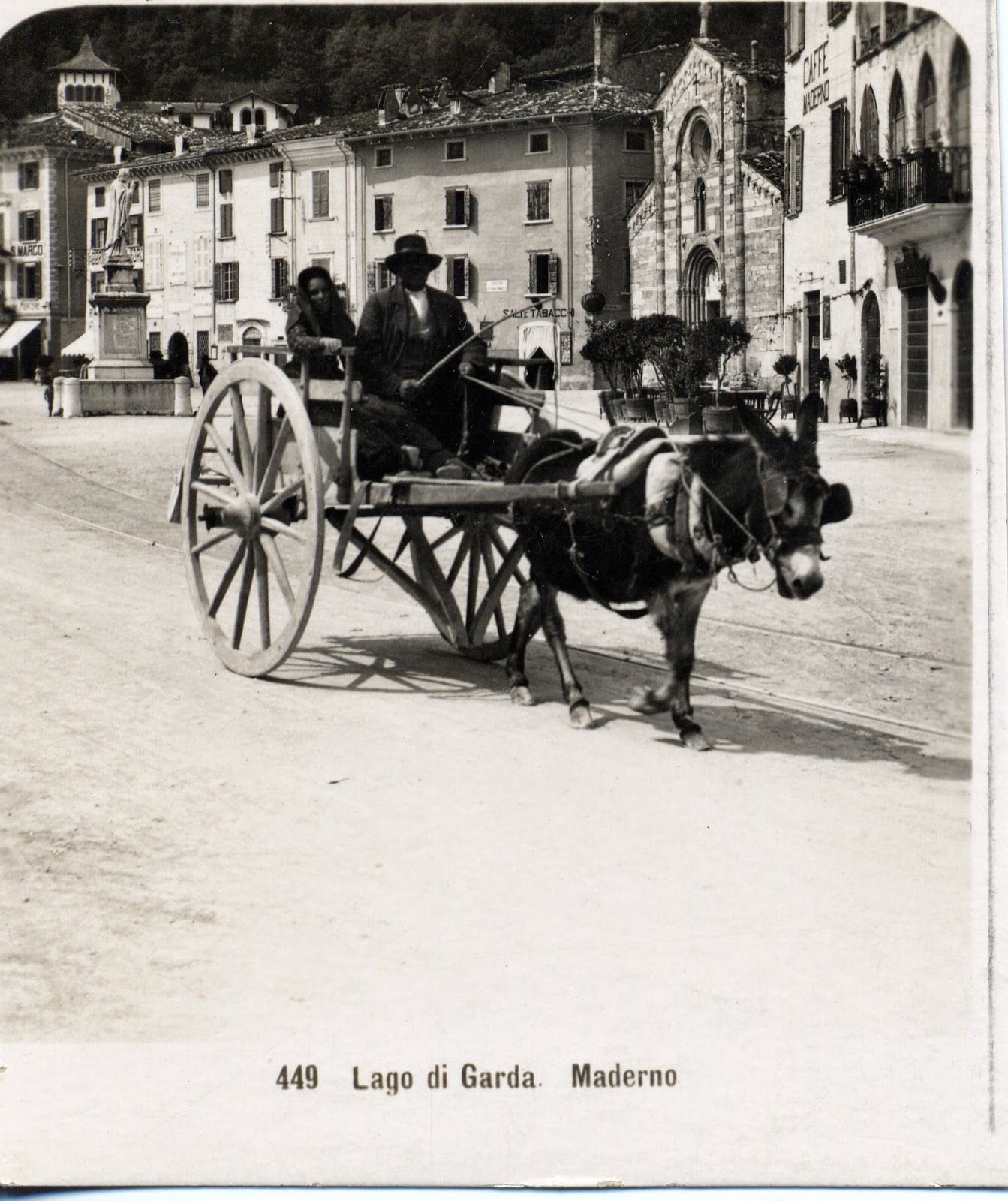Fra le numerose ed interessanti
pubblicazioni di storia locale, lo storico toscolanese Avv. Donato Fossati, discendente di una delle famiglie più in vista
della riviera, nato a Toscolano il 6.10.1870 e morto a Salò il 14.8.1949,
pubblicò anche due volumi riguardanti “Storie e leggende”. Durante la sua
carriera rivestì numerose cariche pubbliche e per ultima quella di Sindaco di
Salò, dal 1945 al 1946.
Nel vol.I°,
fra le altre, vi è compresa la storia dell’astrologo di Gaino che lo stesso
Fossati ebbe la possibilità di conoscere in quanto frequentava a Gaino una casa
di amici, denominata “Selve” perché anticamente era circondata da boschi di
conifere. La stessa casa, nell’800 era appartenuta al colonnello Pietro
Grisetti, reduce dalle campagne napoleoniche a fianco di Gioachino Murat e poi
affiliato alla carbonerie. In questa villa ospitale conobbe anche artigiani e
contadini dai quali apprese varie vicende familiari, avvenimenti del passato e
giudizi su persone e fatti. In particolare il Fossati si sofferma su quella di
Giacomo Zucchelli, da tutti chiamato “astrologo”.
Giacomo
Zucchelli, sessantenne, dimorante in un
abituro (bugigattolo) appollaiato su un dosso al di sopra della frazione
di Cussaga, reminescenza longobarda da Cuz (prestazione agraria) dove lavorava
un po’ di magra terra bastevole alla sua esistenza; aveva militato in gioventù
nella Guardia di Finanza quando questo corpo era inviso alle popolazioni, (i
militari erano chiamati spadasì). Aveva l’ingrato compito di reprimere il
contrabbando esercitato su larga scala in Riviera da dove i contrabbandieri due
volte la settimana in poche ore, sorpassata la montagna di Vesta allora linea
di confine con l’Austria e calati a Bollone in Valle di Vestino, ritornavano
carichi di tabacco, di zucchero e specialmente di alcool, che con rilevante
lucro rivendevano ai produttori d’acqua di cedro.. Era scapolo, vegeto e
arzillo il vecchio milite della foresta, pronto di favella e arguto filosofo
nei giorni di buona luna, ma in altri si sentiva colombrio, così si esprimeva,voleva dire imbronciato, taciturno e
in preda a melanconia e allora rimaneva tappato in casa; aveva la passione o
meglio la mania della scienza astronomica e la testa rimpinzata di empirismi,
di formule e di cabale e dalla osservazione delle stelle alla quale si dedicava
ogni notte serena anche d’inverno sedendo sul tetto della casa, munito di un
cannocchiale dell’epoca di Galileo, strologava, secondo la sua espressione,
il tempo e gli uomini, voleva dire che prediceva le vicende atmosferiche e
prevedeva le fortune e i malanni delle famiglie dei mortali: astronomo dunque e
astrologo.
Molti si
facevano giuoco del buon Zucchelli, ma altri prendevano per buona moneta le sue
stravaganti profezie esposte con serietà e convinzione tra un viluppo di frasi
e di parole o misteriose o incomprensibili: diceva che la sua migliore
confidente era la luna sempre arrendevole e compiacente che le stelle parlavano
al suo orecchio fischiando, che gli astri non sempre rispondevano e altre
consimili scioccherie, ma non si apriva intorno ai suoi metodi per interpretare
le varie fischiate, le confidenze e gli atteggiamenti benevoli od ostili delle
sue divinità celesti, riluttante sempre a dare l’oroscopo del Fossati, quando
un giorno finalmente lo prese in
disparte e, a voce bassa, gli comunicò che Giove ripetutamente interpellato non
aveva mai risposto e che Venere sgarbata e iraconda l’aveva coperto di
contumelie parecchie volte, che però da altre captazioni aveva assodato che
avrebbe avuto vita lunga, carriera politica, sfortuna in amore, disgrazie nella
famiglia e molti figli.
Era un
pazzoide sempre tranquillo e innocuo il povero solitario astrologo, né il
manicomio lo prese, come molti prevedevano, morì ai settant’anni in una rigida
primavera, di polmonite doppia, vittima delle sue veglie notturne, sereno e
rassegnato, persuaso di salire a tener compagnia ai profeti suoi predecessori e
di meritare il premio del Paradiso.
Lo stesso
Fossati ricorda però che Gaino diede i natali anche a personaggi che si resero
notevoli anche nel campo degli studi, fra i quali ricorda il Prof. Don Giuseppe Avanzini(1753-1827)
docente all’Università di Padova e matematico illustre, due altri omonimi Michele del secolo XVII e Filippo noto bibliotecario a Padova nel
XVIII secolo, i Conti Delay
ambasciatori, scrittori, amici di imperatori oltreché industriali
intraprendenti, i due Cristoforo Pilati
protonotario (uno dei 7 grandi ufficiali del Regno di Sicilia e primo
Segretario del Re) e visitatore apostolico il primo, amico di S.Carlo Borromeo
e naturalista-geologo il secondo, morto in Brescia nel 1805, Sansoni Bortolo latinista, oratore,
scrittore e distinto pittore, il Prof .Pietro
Zaniboni docente a Padova e romanziere, il Dr. Prof. Gio Battista Salvadori medico chirurgo (1853-1928), il Ten.Gen.le Gazzurelli (1837-1914) noto per la sua
campagna d’Africa e da ultimo il Prof.Ferruccio Zaniboni, figlio del
precedente, insegnante di lettere al liceo classico di Brescia, poeta e fine
scrittore.
scrittore.
scrittore.
scrittore.